[ad_1]
di FRANCESCO GRECO – TRICASE (LE). E’ attribuita a Tolstoj: “Parla del tuo villaggio e sarai universale”. E’ la poiesis che si è data di Alfredo De Giuseppe (Tricase, 1958), cineasta, poeta, scrittore, intellettuale, con una personale visione del mondo, la natura, il reale, l’orizzonte, l’uomo in fieri, la sua anima ignota a se stesso.
E’ Il filo rosso che attraversa tutta la sua opera sotto l’aspetto artistico ed estetico. Ha elevato la città natale a topos che affolla di una ricca e complessa semantica e che fa da spettro per osservare il mondo. Il richiamo più istintivo è Garcìa-Màrquez, Macondo, villaggio il grumo di passioni e di magia è fascinoso.
In perfetta continuità, è anche la password di quest’ultima opera, “l’abbandono”, un corto di circa un quarto d’ora ideato e girato in pochi giorni (ottobre 2017), con una rabbia escatologica, come colto da un’illuminazione per cui si decide di fermare un sentimento intriso di pietas e furore, e di scandalo per la perduta bellezza, per la deriva nichilista in cui siamo immersi, per la quotidianità lacerata modulata sulla bruttezza che dallo sguardo, per transfert, sconfina nel paesaggio di piastrelle lucide e porte d’alluminio fra le antiche pietre, a svelare ai posteri tanta volgarità.
“L’abbandono” (presentato nel sontuoso Palazzo Gallone dalla libreria Marescritto, Meditinere e il “Volantino”, patrocinio del Comune, col sindaco Carlo Chiuri, l’avv. Alessandro Distante, il sociologo Gino Za, l’arch. Rocco De Matteis, il prof. Giovanni Carità, ) si trasfigura così in una favola amara, un pugno sui denti, una provocazione intellettuale cool, un “urlo” alla Munch per questa lebbra silenziosa e inesorabile che ha invaso i nostri cuori, corrotto la percezione e le difese immunitarie, ci ha resi insensibili alla bellezza, gonfi d’indifferenza, spesso violenti e cattivi.
Ma il degrado del rione “Puzzu” (il cuore settecentesco del centro antico della città) va letta anche come metafora nuda di un universo, il Mezzogiorno, a cui apparteniamo per la disgrazia d’essere nati (come direbbe il sublime Cioran) ma che ormai ci sta diventando estraneo e a tratti ostile, spianando la via alla fuga disperata.
Dal “Puzzu” tutti sono scappati (start 4 ottobre 1964, il “botto” della fabbrichetta di botti) per un sottinteso, infido esproprio culturale: non fa status restare in un rione povero se si cambia censo: se si fanno i soldi, si può vivere anche senza memoria, radici, identità. Meglio la villa pacchiana senza stile e intorno un ettaro di terra. Quelle case se le compreranno i forestieri, le restaureranno, le valorizzeranno. E’ il mercato, bellezza, ogni poesia è formattata.
Ciò che accade nel rione (detto anche “Stradelle”), il “degrado umano e culturale”, per transfert diviene dunque lo specchio fedele di un Sud desertificato, umanamente e materialmente (“Vendesi” ovunque), un mondo sfatto, confuso, schizofrenico, in putrefazione, che non offre un futuro, senza una classe dirigente degna, non ripiegata sui propri benefit castali, una borghesia un po’ illuminata, un ceto politico che non sia di rozzi mestieranti e cinici avventurieri sempre sul confine della galera, attaccati al posto sicuro nel listino (finché l’antipolitica non li spazzerà via mandandoli a lavorare), intellettuali spenti (al di là dell’ideologia di derivazione) che non masturbino il reale. Tuttavia il Sud funziona, ha delle (esigue) eccellenze, in un contesto di degrado, di barbarie, un mondo che si regge sul fai da te, genio e sregolatezza, start-up vincenti, ricercatori ostinati, e di pensionati e badanti, pusher e politici senza peso specifico.
Ma se la speranza ci sfiora come uno “scandalo”, fra le righe dell’opera si intravede un’esile luce. Attorno al pozzo senza acqua, là dove ieri brulicava un’umanità dolente e virile, tenuta insieme da un magico plancton universale che solo i poveri conoscono, oggi non ci sono bambini ma la sera i ragazzini indugiano colmi di un’energia che cogli nell’aria, attirati dall’odore di olio fritto di una pizzeria, in una movida povera e ingenua, da borgata pasoliniana; il barbiere aspetta clienti sulla porta; il calzolaio risuola le scarpe della festa. Gli irriducibili abitanti hanno messo in scena il “botto”, e c’è persino un folle che ha aperto il varco a una modernità feticista che sublima il tutto nel segno con una botteguccia di tatuaggi. Forse i bambini e le mamme presto torneranno?
L’opera di De Giuseppe sfrutta i codici del cinema neorealista, sospesa fra l’asprezza poetica di Rossellini e De Sica e l’afflato socio-antropologico alla Nanni Loy (ricordate l’avventore che inzuppa il cornetto nel cappuccino altrui?), e conferma – in questo scorcio di III Millennio – di aver afferrato il mood profondo della nostra anima mediterranea, il dna polisemico delle culture che compongono il nostro sangue e la memoria, più di altri registi con più visibilità mediatica, che affastellano banalità e luoghi comuni.
Questo è il cinema che ci emoziona, che ci riduce al silenzio: come accade dinanzi alla poesia.
[ad_2]
Source link
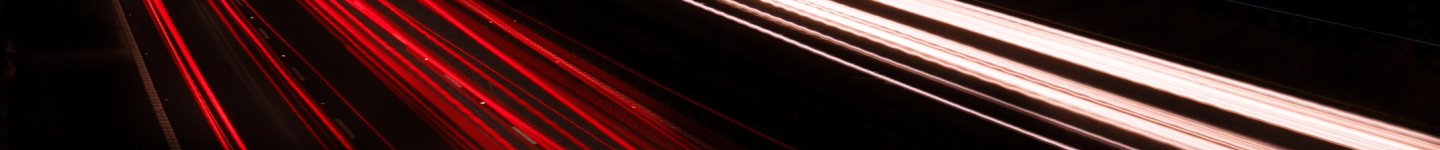




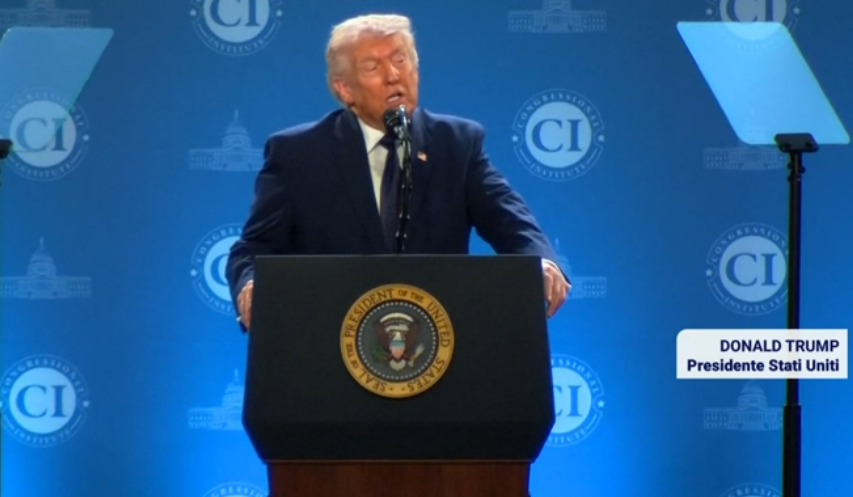
Leave a Reply